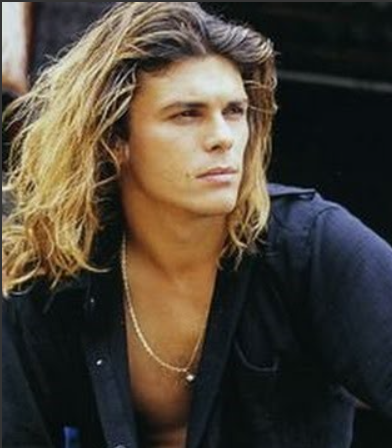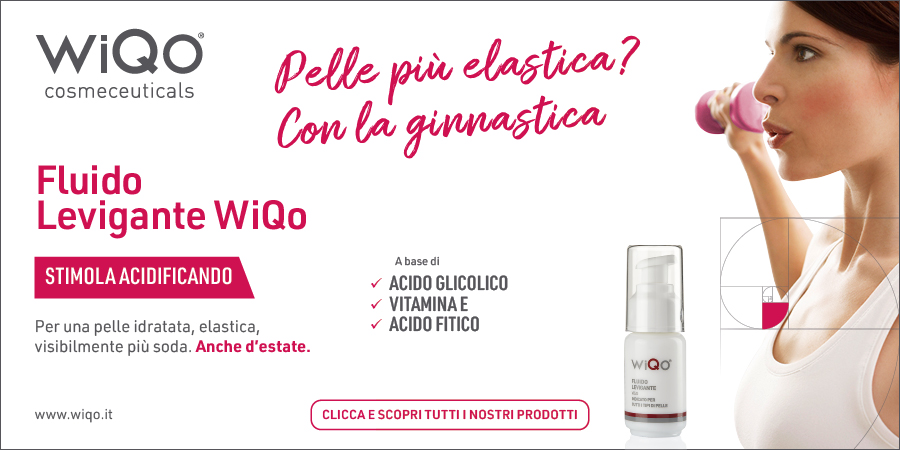Rigoberta Menchú, la voce che ha sfidato l’oblio e raccontato l’anima di un popolo
Rigoberta Menchú: la voce dei senza voce
Immagina una ragazza che nasce in un villaggio sperduto del Guatemala, a tremila metri d’altezza, tra i boschi e le montagne che odorano di terra e resistenza. Si chiama Rigoberta, figlia di contadini indigeni, quelli che la storia ha sempre provato a cancellare col bianchetto. Solo che lei, di sparire, non ne ha mai avuto voglia. Anzi.
La sua infanzia è un mosaico di povertà e orgoglio. A otto anni lavora nei campi. A dodici, capisce già che il mondo non è giusto, che c’è chi comanda e chi muore in silenzio. Parla quiché, la lingua del suo popolo, e impara lo spagnolo più tardi, ma le sue parole, anche nella seconda lingua, diventano pietre e carezze.
Negli anni Settanta, in Guatemala, il governo massacra i contadini come se fossero insetti. Sparizioni, torture, case bruciate. La sua famiglia viene travolta: torturano il fratello davanti alla gente, bruciano vivo il padre durante un assedio a Città del Guatemala, stuprano e uccidono la madre. E lei? Non fugge. Si trasforma.
Rigoberta comincia a parlare. Raccontare. Resistere. Va nelle comunità indigene, poi nelle scuole, poi nei congressi. Fino a quando, nel 1982, esce un libro che è come un urlo che attraversa l’oceano: “Mi chiamo Rigoberta Menchú e così mi è nata la coscienza”. È un’esplosione. Le parole pulsano, fanno male come le verità che nessuno vuole ascoltare. Il mondo, finalmente, si gira a guardare l’America Latina che sanguina.

Nel 1992 riceve il Premio Nobel per la Pace. Ha 33 anni. Non si mette la corona in testa: la divide con gli altri, con quelli che non l’hanno mai avuta. Dice: “Questo premio non è per me, è per il mio popolo”. Continua a lottare, con la voce, con i gesti, con una dignità che non ha bisogno di grandi frasi.
Rigoberta non si piega. Non perché sia dura, ma perché è radice. Porta dentro la forza di milioni di donne e uomini che non hanno mai avuto un microfono, ma che hanno sempre avuto la verità.
E oggi? È ancora lì. A parlare di diritti, ingiustizia, ambiente, pace. A ricordarci che il mondo non cambia da solo. Che bisogna volerlo. E raccontarlo. Come ha fatto lei, con il fuoco negli occhi e la terra nel cuore.
Un grazie che guarda al futuro
E alla fine, permettetemi un grazie speciale. A Daniele, un ragazzino di 12 anni che mi ha parlato di lei con gli occhi accesi dalla curiosità. Perché sono proprio loro, i giovanissimi, ad avere più fame di verità e più bisogno di cultura. E noi adulti, se siamo fortunati, possiamo ancora imparare da loro. Anche solo il coraggio di raccontare.
Leggi anche: Il bidello torna in tribunale: la verità è attesa